Lavoro part time: la normativa e la giurisprudenza di merito e di legittimità
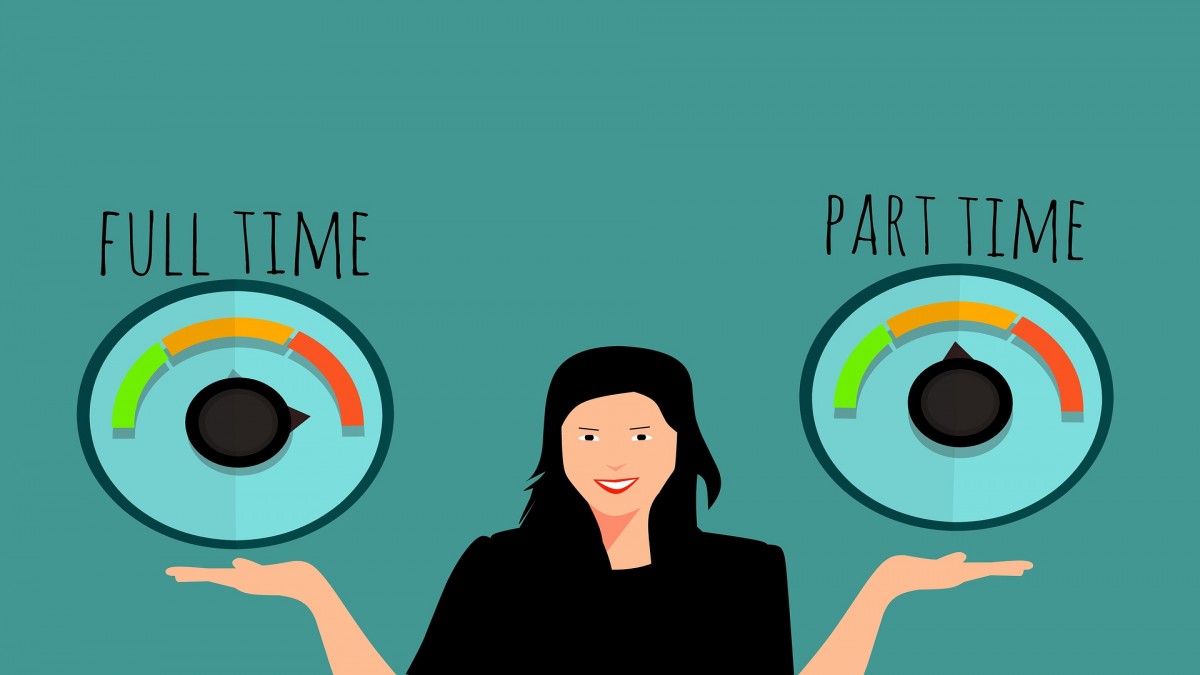
Notoriamente, nel nostro Paese, l’onere di soddisfare queste esigenze è sempre gravato (e tuttora grava), in netta prevalenza, sulle donne, tanto da poter condividere il giudizio secondo cui il part-time può essere considerato un fedele alleato delle rappresentanti del sesso femminile, nonché risposta pragmatica ad una realtà sociale che, ancora troppo spesso, affida per lo più ad esse la responsabilità della gestione della casa e della famiglia.
Dati statistici dell’Inps – riferiti da affidabile fonte sindacale – documenterebbero che, nel 2022, nei settori privati il 47,7% delle donne ha un contratto part-time contro il 17,4% degli uomini, con differenze ulteriori tra le aree del Paese che vedono maggiormente penalizzate le lavoratrici del Mezzogiorno, Calabria e Sicilia in testa.
Part-time spesso involontario, non liberamente scelto.
Nel settore del pubblico impiego, la differenza diminuisce ma resta preponderante per le donne rispetto agli uomini. Assetti che, inevitabilmente, hanno ripercussioni sulle retribuzioni annue e sugli assegni pensionistici ove i relativi trattamenti risulterebbero, per le donne, mediamente inferiori a quelli maschili del 36%. In pratica, mentre l’importo medio mensile dei redditi da pensione di un uomo è di 1.932 €, quello delle donne è di 1.416 €.
Di fronte a questa realtà sociale, il legislatore non poteva rimanere inattivo, cosicché si determinò a disciplinare la fattispecie del lavoro a tempo parziale con l’emanazione della L. 19 dicembre 1984, n. 863. Prima dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale era demandata – in forma esclusiva – alla contrattazione collettiva, che ha rappresentato per molto tempo l’unico strumento in grado di regolare e di gestire il rapporto a part-time.
A dare nuovo impulso e nuovo rigore alla disciplina normativa è stato però il sopraggiungere dell’intervento del legislatore comunitario e della direttiva n. 97/81/CE, attuativa dell’accordo collettivo quadro a livello europeo del 6 giugno 1997. In seguito all’intervento di cui sopra e nonostante il contenuto della L. n. 863 del 1984 fosse già, in buona sostanza, allineato ai principi fondamentali contenuti all’interno di tale direttiva (principio di non discriminazione, principio pro rata temporis), il nostro legislatore colse – con l’emanazione del predetto provvedimento comunitario – l’occasione per riscrivere interamente la disciplina nazionale del lavoro a tempo parziale, abrogando la legge in vigore ed emanando, il d. lgs. n. 61 del 2000.
Al provvedimento di cui sopra hanno quindi fatto seguito ulteriori modifiche ed integrazioni alla disciplina del rapporto a tempo parziale, mediante le disposizioni contenute nella L. n. 247 del 2007, nella L. n. 183 del 2011, oltreché nella L. 92 del 2012 (cd. riforma Fornero). Infine è intervenuto il d.lgs. n. 81/2015 (in applicazione del cd. Jobs act del governo Renzi) che – dichiarando [(tramite l’art. 55, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 15/6/2015)] abrogata, a decorrere dal 25 giugno 2015, la precedente disciplina di cui al d.lgs. n.61/2000 – ha riscritto (negli art. da 4 a 12) la regolamentazione del rapporto di lavoro a part-time.
Tuttavia nuova regolamentazione nazionale che è sortita dall’abrogazione delle previgenti, ha riconfermato il fondamentale principio di “non discriminazione del lavoro a part-time” rispetto al tempo pieno – già sancito nell’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, che a sua volta recepiva il principio di fondo ispiratore della direttiva 97/81/CE e della Convenzione O.I.L. n. 175/1994, secondo il quale il lavoratore part-time, in linea di massima, non può subire un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno. Riaffermandolo, tuttavia, tramite una formulazione più concisa ma sostanzialmente equivalente e garantista, espressa nell’art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, che così recita: «1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. 2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro».
2. Le disapplicazioni aziendali della normativa e le distorte interpretazioni aziendali
Nonostante tale specificazione antidiscriminatoria dei diritti del lavoratore part-time, la magistratura si è dovuta occupare, in concreto, di storture applicative di segno discriminatorio da parte delle aziende, praticate eminentemente in ragione di una preconcetta e malcelata ostilità a tale forma di resa della prestazione – ritenuta intimamente indicativa e rea di una sorta di disaffezione verso gli interessi dell’azienda – quando invece alla sua richiesta ricorrevano eminentemente le lavoratrici prive di supporti collaborativi onde conciliare il lavoro d’ufficio o di fabbrica con i gravosi impegni familiari costituiti dalla necessità di accudire alla prole, di assistere e curare i genitori malati o anziani.
Prevalente nella discriminazione si è rivelata la prassi – attivata da molteplici istituzioni pubbliche e private – di procedere ad un “riproporzionamento (al ribasso)” dell’anzianità di servizio dei lavoratori a part-time (prevalentemente lavoratrici), in ragione delle inferiori ore di prestazione settimanale (esemplificativamente 25 rispetto alle 37,30 del tempo pieno). E notorio che – nella disciplina regolamentare di strutture o istituzioni di natura pubblicistica come in diversi ccnl applicati da aziende private di taluni importanti settori economici – la progressione professionale da un livello economico inferiore a quello superiore è correlata, in maniera automatica o semi automatica, all’anzianità di servizio.
Tanto premesso, riteniamo opportuno evidenziare, in concreto, gli effetti pregiudizievoli del criterio del ripropozionamento dell’anzianità lavoratori a part-time, prospettando l’iniquità del fatto che, mentre per i lavoratori a tempo pieno l’anzianità di servizio utile per il passaggio semiautomatico o automatico al grado/livello superiore – stabilita, ad esempio, in 2 anni dai regolamenti o dai contratti collettivi applicati in azienda, – per i lavoratori a part-time (assunti in pari data dei colleghi a tempo pieno), la loro anzianità di servizio risultava, ridotta, ad esempio, in un anno e mezzo. Ciò a causa di un irragionevole/inapplicabile ricorso, da parte aziendale, al riproporzionamento (cd. pro rata remporis) della loro anzianità di servizio sulla base delle minori ore lavorative prestate in dipendenza della tipologia “a tempo parziale” del loro rapporto di lavoro. Cosicché il lavoratore a part-time, alle dipendenze dell’azienda da 2 anni (alla pari del collega a tempo pieno), doveva aspettare un altro mezzo anno (6 mesi) per fruire dell’avanzamento di grado/livello economico superiore, con un intuitivo pregiudizio economico.
Ma lo svantaggio maggiore – cioè la discriminazione professionale a contenuto economico, per i lavoratori a part-time – si attualizzava in occasione delle promozioni professionali per merito comparativo a numero chiuso, contemplate dalla regolamentazione di istituzioni, enti o agenzie di tipo pubblicistico (ASL, Agenzia dell’Entrate e simili) ovvero previste in contratti collettivi nazionali/aziendali di imprese private di importanti settori economici nazionali. Infatti, poiché le promozioni (a numero chiuso) al livello economico superiore venivano effettuate sulla base di graduatorie aziendali scaturite da punteggi assegnati ai candidati in base all’anzianità di servizio (ipotizzata attestante esperienza rifluente acriticamente in presunta competenza), i lavoratori a part-time – la cui anzianità di servizio era stata riproporzionata per le minori ore lavorate rispetto a quella dei lavoratori full-time – ricevevano, in graduatoria, i punteggi più bassi e, pertanto, restavano esclusi dalle promozioni.
In buona sostanza, il riproporzionamento (pro rata temporis), ragionevolmente previsto e applicato per le componenti del trattamento economico sconfinava – nella fase di applicazione da parte dei gestori aziendali – altresì sul calcolo dell’anzianità di servizio, utilizzata quale parametro per la progressione economico/professionale o avanzamento di carriera.
L’errata estensione del criterio del “pro rata temporis” dal trattamento retributivo alla nozione e quantificazione dell’anzianità di servizio alle dipendenze dell’azienda, venne contestata dai lavoratori (rectius dalle lavoratrici, costituenti la compagine maggioritaria dei ricorrenti al part-time), quindi sottoposta al vaglio giudiziale tramite ricorso al magistrato, adducendo fondatamente che la dilatazione datoriale del “riproporzionamento“ dal trattamento economico all’istituto normativo dell’anzianità di servizio (assunta quale metro di misura della maggiore o minore esperienza, competenza e abilità nel lavoro), danneggiava indebitamente l’intera categoria dei lavoratori a tempo parziale. Quindi concretizzava un trattamento discriminatorio e di sfavore per i lavoratori a part-time in raffronto a quelli a full-time; e qualora la maggioranza dei soggetti discriminati risultasse di sesso femminile (come lo è nella stragrande maggioranza dei casi) costituiva discriminazione indiretta di genere, ai sensi dell’art. 25 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. n. 198/2006).
Al riguardo va evidenziato che la nostra legislazione, cioè l’art. 25, co. 2, del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità che, sul punto, riprende la definizione comunitaria), stabilisce che la discriminazione indiretta di genere si attualizza «quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari». Mentre la discriminazione diretta ricorre – secondo l’art. 25, co. 1, del d.lgs. n. 198/2006 (cd. Codice delle Pari Opportunità) – in presenza di «qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga».
E’ stato, peraltro, correttamente osservato () come, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, siano in ogni caso possibili deroghe al divieto di discriminazione nelle particolari ipotesi di attività lavorative in cui il sesso rappresenta una condizione determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa; è, ad esempio, il caso dell’assunzione di soli lavoratori uomini o di sole lavoratrici donne nel campo della moda, con la finalità di partecipare ad una sfilata per una collezione maschile o femminile. In tali ipotesi, la discriminazione all’accesso al lavoro è quindi del tutto legittima.
3. L’intervento risolutivo della magistratura di merito e di Cassazione
Quanto al criterio del cd. riproporzionamento è stato, altresì condivisibilmente osservato () come il cd. “pro rata temporis” costituisca principio immanente dell’ordinamento giuridico giacché espressione del diritto inviolabile di eguaglianza sostanziale presente nei Trattati e nelle Carte costituzionali degli Stati membri. Tale principio prevede che il trattamento del lavoratore a tempo parziale debba essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, impedendo in tal modo che situazioni diseguali siano trattate in modo uguale e situazioni eguali siano trattate in modo diseguale. Da questo punto di vista, quindi, il “pro rata temporis” costituisce l’applicazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità del lavoro prestato, previsto dall’art. 36 Cost., rappresentando, al tempo stesso, una conferma della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro.
Se però, per quanto riguarda la retribuzione base, il riproporzionamento è da considerarsi legittimo, non altrettanto è asseribile per la progressione economica in ragione dell’anzianità di servizio. Ed in tal senso si sono espresse le decisioni della Cassazione che si sono occupate del contenzioso portato al loro esame.
La più recente sentenza che ha consolidato l’orientamento (oramai pacifico) assertore dell’illegittima estensione del criterio del riproporzionamento (pro rata temporis) – ragionevolmente riservabile al trattamento economico dei prestatori a tempo parziale – al diverso istituto normativo dell’anzianità di servizio, è costituita da Cass., sez. lav., 19 febbraio 2024, n. 4313 (rel. Zuliani), preceduta da: Cass. n. 10328/2023 (rel. Fedele), Cass. n. 21801/2021 (Rel. Spena), e, in sede di merito, da Corte d’appello Napoli del 27 febbraio 2020.
Quest’ultima pregevole sentenza di merito del 2020, ha – a nostro avviso – fatto da apripista per le successive precitate sentenze di Cassazione che ne hanno, in sostanza, condiviso e, conseguentemente, replicato le argomentazioni (di cui diremo in prosieguo, una volta illustrate le motivazioni della sentenza napoletana).
Le motivazioni della Corte d’appello di Napoli vennero rese in una causa azionata da una lavoratrice dell’Agenzia delle Entrate che, ai fini di un avanzamento semiautomatico di carriera correlato al parametro dell’esperienza professionale – individuato presuntivamente nell’anzianità di servizio – si era vista sottoporre a riproporzionamento (in correlazione alle minori ore lavorative del suo rapporto a tempo parziale) l’anzianità di servizio utile alla progressione di carriera, e, quindi, escludere dal beneficio promotivo.
Richiamando – per necessaria applicabilità ratione temporis i commi 1 e 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, statuente il principio di non discriminazione nel lavoro a part-time – la Corte d’appello napoletana giunse ad affermare che: «Le ipotesi di “riproporzìonamento” di cui alla lett. b), (della regolamentazione applicata in Agenzia delle Entrate, ndr) contrariamente alla regola generale della parità di trattamento di cui alla lett. a), (…), sono tassative e tra di esse non è prevista la valutazione della professionalità del lavoratore a tempo parziale (melius, il computo dell’anzianità di servizio ai fini della valutazione della professionalità del lavoratore a tempo parziale). Orbene, occorre considerare che il divieto di discriminazione dei lavoratori subordinati a tempo parziale deriva dalla disciplina euro unitaria. La clausola n. 4 (“Princìpio di non discriminazione”) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra te organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), cui la direttiva Dir. 15/12/1997, n. 97/81/CE ha dato attuazione, dispone:
1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”.
3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali (…). In ordine alla giustificabilità per ragioni obiettive di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, secondo la Corte di giustizia le disparità possono essere giustificate solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessario (…). Più specificamente, in relazione al rapporto tra anzianità di servizio e prestazione di lavoro effettivo da un lato, e accrescimento della professionalità in virtù dell’acquisizione di una maggiore esperienza dall’altro, ad avviso della Corte di giustizia (sentenze 7.2.1991, Nimz, C-184/89, ecc.), se è vero che la prestazione di lavoro effettivo va di pari passo con l’esperienza professionale e pone di regola il lavoratore in grado di meglio espletare le proprie mansioni (di qui la necessità di un diverso criterio di valutazione della professionalità tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale), l’obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto e, in particolare, dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e l’esperienza che l’espletamento di tali mansioni fa acquisire dopo un determinato numero di ore di lavoro effettuate. Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate, parte odierna appellante, non ha sviluppato alcun valido motivo atto a sostenere che il “riproporzionamento” in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa era funzionale al passaggio retributivo. In particolare, nessuna precisazione è stata effettuata in merito all’incidenza dell’orario dì lavoro osservato sulla acquisizione del grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. In assenza di tali indicazioni specifiche, l’assiomatica affermazione dell’esistenza di un nesso particolare tra la durata di un’attività lavorativa e l’acquisizione di un certo livello di conoscenza o di esperienza rappresenta una generalizzazione riguardante determinate categorie di lavoratori e non consente di trarre criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione. In definitiva, (…), si ritiene che il “riproporzionamento” sulla base del lavoro effettivamente svolto dell’anzianità di servizio, ai fini della valutazione della professionalità del lavoratore a tempo parziale, nel caso in esame determini una discriminazione in pregiudizio dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, poiché non è stato dedotta né provata la sussistenza di una ragione oggettiva consistente nel nesso eziologico tra espletamento delle mansioni per un orario ordinario e accrescimento dell’esperienza professionale».
Analoghe le motivazioni delle precitate, successive, sentenze di Cassazione, di cui riferiamo quelle della più recente n. 4313 del 19 febbraio 2024,.
Anche questa sentenza è stata occasionata dal ricorso di una lavoratrice a part-time dell’Agenzia delle entrate di Genova (assunta in data anteriore a quella di un collega di sesso maschile con rapporto di lavoro a tempo pieno), che – nella graduatoria aziendale dei candidati per le promozioni professionali di merito a numero chiuso, redatta utilizzando il parametro dell’anzianità di servizio quale metro di valutazione della maggiore o minore professionalità e competenza dei dipendenti -, si era vista assegnare un punteggio inferiore a quello del collega di sesso maschile, assunto in data posteriore, ma con rapporto di lavoro full-time nonché esclusa dalla promozione economica, fruita invece dal collega a tempo pieno di sesso maschile.
La lavoratrice ricorreva in giudizio deducendo che la riduzione della sua anzianità di servizio – per indebita applicazione del criterio del riproporzionamento (cd. pro rata temporis) all’istituto normativo dell’anzianità di servizio – aveva occasionato un palese trattamento discriminatorio, in violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 61 del 2000 (con cui la Repubblica italiana aveva dato attuazione alla direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES).
La Cassazione ha ritenuto di condividere le statuizioni delle Corte d’appello di Genova che aveva ritenuto il trattamento deteriore della lavoratrice a part-time riconducibile alla discriminazione indiretta di genere (in violazione dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2006, (Codice delle pari opportunità), giacché in quel contesto aziendale al rapporto di lavoro a tempo parziale erano ricorse, in grande maggioranza, le donne. Ha, altresì, ricusato le argomentazioni addotte dall’Agenzia delle entrate a sostegno della richiesta riforma della sentenza della Corte d’appello di Genova, basate su una presunta legittima generalizzazione del criterio del riproporzionamento a tutte le componenti o istituti del rapporto part-time – sia economico-retributivi sia normativi -, nonché sulla presunta ragionevole considerazione secondo cui al maggior impegno orario dei lavoratori full-time automaticamente si accompagnerebbe l’acquisizione di una superiore professionalità rispetto al lavoratore part-time.
All’opposto la Corte d’appello genovese aveva statuito, sul punto, quanto segue: «Non è … detto che – a parità di anzianità lavorativa – il lavoratore full-time abbia acquisito maggiore esperienza del lavoratore part-time, dipendendo tale preparazione da tante variabili, tra cui anche (ma non solo) la quantità di ore lavorative prestate nel medesimo periodo lavorativo; quantità di ore che tuttavia non assume una rilevanza determinante, essendo sicuramente più importante la qualità delle pratiche seguite dal lavoratore nel corso del rapporto».
La Cassazione in esame, (decisione del 19 febbraio 2024, n. 4313), una volta condivisa la riferita motivazione della Corte di merito, puntualizzava altresì che: «non può esserci alcun automatismo tra riduzione dell’orario di lavoro e riduzione dell’anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche. Occorre invece verificare se, in base alle circostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale. E l’onere della prova dei presupposti di fatto che determinano la razionalità, in tale contesto, del riproporzionamento è a carico del datore di lavoro (v., conf., Cass. n. 10328/2023)».
Concludendo, poi, che «svalutare il part-time ai fini delle economiche orizzontali (ovverosia progressioni economiche non legate ad avanzamenti di carriera, ma comunque meritate, secondo parametri che includono anche l’anzianità di servizio) significa, nei fatti, penalizzare le donne rispetto agli uomini con riguardo a tali miglioramenti di trattamento economico (…) si può poi aggiungere che la preponderante presenza di donne nella scelta per il lavoro a tempo parziale è da collegare al notorio dato sociale del tuttora prevalente loro impegno in ambito familiare e assistenziale, sicché la discriminazione nella progressione economica dei lavoratori part-time andrebbe a penalizzare indirettamente proprio quelle donne che già subiscono un condizionamento nell’accesso al mondo del lavoro.
5. Conclusioni
Il contenzioso sul tema della discriminazione dei lavoratori a part-time (in netta prevalenza di sesso femminile, come già osservato), rispetto ai lavoratori full-time relativamente alla loro progressione economico-professionale – direttamente conseguente all’indebito riproporzionamento della loro anzianità di servizio – si è manifestato quasi esclusivamente nel comparto del pubblico impiego (Asl, Agenzia delle entrate, Inps, relativamente al riproporzionamento dell’anzianità per l’accesso alla pensione dei lavoratori a part-time verticale).
Ma sarebbe errato ritenere che il settore privato sia risultato estraneo a tale pratica discriminatoria. Semmai va piuttosto detto che, nel comparto delle aziende private, i correttivi a tale pratica discriminatoria – indubbiamente praticata dalle aziende anche senza incorrere in una reazione a livello giudiziale da parte dei/delle discriminate – sono stati affrontati e risolti, prevalentemente, a livello sindacale tra le parti stipulanti i contratti collettivi.
Ne è conferma la disposizione pattizia reperibile, a titolo esemplificativo, nel ccnl del settore creditizio, ove l’allineamento – in via preventiva o in forma di recepimento – all’orientamento antidiscriminatorio della magistratura, innanzi illustrato in questo scritto, lo si riscontra in disposizioni contrattuali del seguente tenore, specificamente convenute in ordine alla nozione di “Anzianità” dei/delle lavoratrici part-time (utile per la maturazione ed il calcolo di vari istituti contrattuali). Così formulate: «Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari del lavoratore part-time deve corrispondere a quella del lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento»;
Nonché, «Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali».
Ed infine, sempre nello stesso ccnl, un’apprezzabile “norma transitoria” – spia, al tempo stesso, di errate prassi pregresse – contempla una loro retroattiva correzione, tramite la seguente formulazione: «nei casi in cui, i periodi trascorsi a tempo parziale, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario, l’impresa dovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° agosto 1999».
() Biagioni T., in Lavoro, diritti, europa, 2023.
() Pezzoni V., in Bollettino ADAPT 8 aprile 2024 n. 14.

